gratuito, fatto solo da romani; di un eloquente riconoscimento del legittimo Sovrano da parte del popolo che plaudendo offriva gli uomini e le braccia.
Questo concetto volle ribadire Leone XIII in una udienza ad alcuni ufficiali della Guardi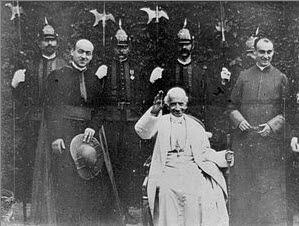 a, tra i quali trovavasi anche il capitano Benincampi, che ne scriveva: Agli omaggi, ai ringraziamenti, agli auguri, Egli rispose di amare le sue Guardie Palatine, perché rappresentavano un plebiscito armato permanente, della devozione e della fedeltà dei romani verso la Santa Sede, e verso il loro legittimo Sovrano, il Papa. Lodò la sua guardia per i nobili servizi in ogni contingenza da essi prestati, con slancio affettuoso e disinteressato. Poi soggiunse: I tempi sono brutti, ma ben peggiori ne minaccia l’avvenire. Io ho posto la mia causa, la causa della Chiesa, nelle mani di Dio; ma confido anche in voi e nel filiale vostro amore.
a, tra i quali trovavasi anche il capitano Benincampi, che ne scriveva: Agli omaggi, ai ringraziamenti, agli auguri, Egli rispose di amare le sue Guardie Palatine, perché rappresentavano un plebiscito armato permanente, della devozione e della fedeltà dei romani verso la Santa Sede, e verso il loro legittimo Sovrano, il Papa. Lodò la sua guardia per i nobili servizi in ogni contingenza da essi prestati, con slancio affettuoso e disinteressato. Poi soggiunse: I tempi sono brutti, ma ben peggiori ne minaccia l’avvenire. Io ho posto la mia causa, la causa della Chiesa, nelle mani di Dio; ma confido anche in voi e nel filiale vostro amore.
Il reggimento continuò a far servizio col solito zelo durante gli anni più dolorosi, me.jpg) ntre le furie dell’anticlericalismo imperversavano e la libertà di pensiero, d’azione, era diventata monopolio di pochi, non certo amici della Chiesa. Il Giubileo universale del 1879, quello del 1881, l’esposizione mondiale in Vaticano dei doni inviati a Leone XIII pel suo giubileo sacerdotale del 1888, offrì alla Guardia non ristretto campo di mostrarela serietà della sua organizzazione, l’importanza del suo compito, la disciplina dei suoi militi, come era già avvenuto pel precedente conclave. S’era allora disposto – e lo sappiamodal relativo rapporto – che una compagnia venisse acquartierata nel cortiletto del Maresciallo, ove, nel Sacro Palazzo Apostolico del Vaticano, vi è l’ingresso c
ntre le furie dell’anticlericalismo imperversavano e la libertà di pensiero, d’azione, era diventata monopolio di pochi, non certo amici della Chiesa. Il Giubileo universale del 1879, quello del 1881, l’esposizione mondiale in Vaticano dei doni inviati a Leone XIII pel suo giubileo sacerdotale del 1888, offrì alla Guardia non ristretto campo di mostrarela serietà della sua organizzazione, l’importanza del suo compito, la disciplina dei suoi militi, come era già avvenuto pel precedente conclave. S’era allora disposto – e lo sappiamodal relativo rapporto – che una compagnia venisse acquartierata nel cortiletto del Maresciallo, ove, nel Sacro Palazzo Apostolico del Vaticano, vi è l’ingresso c.jpg) he in tale circostanza viene riservato per i conclavisti, e [che] colà mettesse una sentinella continua in ciascuna delle rote del Conclave, alle quali presiedevano alcuni Prelati. Prima di notte 13 febbraio 1878 gli Eminentissimi Cardinali fecero ingresso nel Conclave, e l’ordinato servizio militare venne effettuato con la dovuta puntualità.
he in tale circostanza viene riservato per i conclavisti, e [che] colà mettesse una sentinella continua in ciascuna delle rote del Conclave, alle quali presiedevano alcuni Prelati. Prima di notte 13 febbraio 1878 gli Eminentissimi Cardinali fecero ingresso nel Conclave, e l’ordinato servizio militare venne effettuato con la dovuta puntualità.
Il 19 maggio 1889 fra blasfemi tripudi, s’inaugurava in Roma il monumento a Giordano Bruno. La Guardia Palatina accorreva spontaneamente in massa al Vaticano, e vi rimane, vigile, per tre giorni. Nel 1892, sia per le nuove circostanze, sia allo scopo di rendere più attiva l’opera del Corpo, il Pontefice Leone XIII emanò un regolamento, che fu in vigore sino a pochi anni or sono.
Tracciamo le linee principali. La Guardia passò alle dipendenze del Cardinale Segretario di Stato e ri.jpg) cevette gli ordini dal Maggiordomo per i servizi di Palazzo, dal Maestro di Camera per l’anticamera; in seguito abolita la carica di maggiordomo,ogni ordine venne dal secondo. Gli effettivi furono ridotti ad un battaglione di quattro compagnie da 80 a 100 uomini. Si fissò l’età d’arruolamento fra i 18 anni e i 30; necessaria la cittadinanza romana o per nascita o per abituale dimora, ottima condotta religiosa e civile, discreta condizione di vita. Armi e vestiario a carico della Santa Sede, abrogazione di molti privilegi ormai in contrasto coi temp
cevette gli ordini dal Maggiordomo per i servizi di Palazzo, dal Maestro di Camera per l’anticamera; in seguito abolita la carica di maggiordomo,ogni ordine venne dal secondo. Gli effettivi furono ridotti ad un battaglione di quattro compagnie da 80 a 100 uomini. Si fissò l’età d’arruolamento fra i 18 anni e i 30; necessaria la cittadinanza romana o per nascita o per abituale dimora, ottima condotta religiosa e civile, discreta condizione di vita. Armi e vestiario a carico della Santa Sede, abrogazione di molti privilegi ormai in contrasto coi temp.jpg) i.
i.
La Guardia Palatina d’Onore come già la Milizia Urbana, e la Guardia Civica, manda ogni giorno in anticamera un ufficiale ed un picchetto di sei uomini più un graduato. Presta inoltre servizio di sicurezza in periodo di sede vacante, di parata nelle Cappelle papali, nelle visite dei Capi di Stato esteri, e presta tutti quegli altri servizi che, di volta in volta vengono richiesti.
Il resto che è molto, è storia di ieri. Dal Giubileo del 1900 a quelli degli ultimi anni, nel corso di grandi pontificali,sino al tempo nostro, fra trionfali funzioni, commosse udienze, solenni visite sovrane, indimenticabili festose parate negli accoglienti e nostalgici viali dei giardini vaticani,in giorni limpidi e lieti, in ore fortunose e tristi, la Palatina fu sempre indero.jpg) gabilmente presente e caldamente fedele, riscuotendo l’ambito elogio e le paterne benevolenze di Pio X, Benedetto XV, Pio XI, e del regnante Pio XII. Ed intanto veniva giù col volgere perenne degli anni, attivi e cavallereschi comandanti dal marchese Giuseppe Guglielmi, al marchese Giovanni Lepri, (1878-
1883), al conte Antonio Spreca (1884-1886), al commendator Fortunato Crostaros
gabilmente presente e caldamente fedele, riscuotendo l’ambito elogio e le paterne benevolenze di Pio X, Benedetto XV, Pio XI, e del regnante Pio XII. Ed intanto veniva giù col volgere perenne degli anni, attivi e cavallereschi comandanti dal marchese Giuseppe Guglielmi, al marchese Giovanni Lepri, (1878-
1883), al conte Antonio Spreca (1884-1886), al commendator Fortunato Crostaros.jpg) a (1887-1903), al conte Camillo Pecci (1903-1912),al commendator Giovanni Battista Di Pietro (1912-1916), al conte Mario Carpegna (1916-1919), al commendator Odoardo Tabanelli (1919-1929), al grande ufficiale Enrico Vuillemenot (1931-1937), ed infine al conte Francesco Cantuti (1937-1970).
a (1887-1903), al conte Camillo Pecci (1903-1912),al commendator Giovanni Battista Di Pietro (1912-1916), al conte Mario Carpegna (1916-1919), al commendator Odoardo Tabanelli (1919-1929), al grande ufficiale Enrico Vuillemenot (1931-1937), ed infine al conte Francesco Cantuti (1937-1970).
Pagato non lieve tributo di mobilitati e di sangue alla Patria comune nel corso della guerra europea, presto ricomponendosi e sempre più prosperando, vide con gioia indescrivibile realizzarsi l’auspicata Conciliazione, che spegnendo per sempre l’eco ormai lontana di fatali e dolorosi contrasti, l’ha resa milizia volontaria di figli devoti e di riverenti diocesani intorno al Papa, Vescovo di Roma.
Da allora in poi gli organi di comando hanno saputo attivamente promuovere e vengono curando con felice intuito e con notevole efficacia molteplici riforme e variate iniziative volte a sempre meglio mettere il Corpo nella possibilità di corrispondere in pieno, e moralmente, e materialmente ai nuovi come ai vecchi doveri.
Questa breve storia è stata realizzata ricomponendo 8 articoli apparsi si “Vita Palatina” negli anni 40 del passato secolo.
| Inizio pagina | Pagina precedente |




